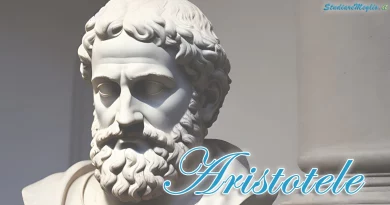Anselmo d’Aosta
Difensore di una ricerca tenente conto della fede, ma non per questo sbarazzantesi della ragione, Anselmo (nato ad Aosta nel 1033) entrò nell’abbazia benedettina di Bec in Normandia , dove era abate Lanfranco di Pavia, e nel 1066 divenne monaco. Successe poi a Lanfranco dapprima nella carica di abate, nel 1078, e, nel 1093, in quella di arcivescovo di Canterbury . Qui si trovò a dover difendere le prerogative e l’ autonomia della Chiesa contro i sovrani normanni d’ Inghilterra , sino alla sua morte avvenuta nel 1109.
Verso il 1076 compose il Monologio, cioè soliloquio , da lui considerato “un esempio di meditazione” sulle ragioni della fede . Nei due anni successivi scrisse il Proslogio , cioè colloquio, intitolato anche (con espressione agostiniana) “Fides quaerens intellectum” (la fede alla ricerca di intendimento): è importante il fatto che Anselmo parli di intelletto e non di ragione, poiché il primo è uno strumento intuitivo, mentre la seconda è, piuttosto, un’arma discorsiva.
Dopo che il monaco dell’ abbazia di Marmoutier, Gaunilone , intervenne nella discussione sul problema dell’esistenza di Dio, affrontato da Anselmo nel Proslogio , con un “Libro in difesa dell’insipiente“, Anselmo compose un “Libro apologetico contro Gaunilone“. Altri scritti di epoca probabilmente successiva sono : “Sulla verità“, “Sulla libertà di arbitrio“, “Sul grammatico“, “Sulla concordia della scienza e della predestinazione“. Verso la fine della sua vita Anselmo compose il “Perchè Dio si é fatto uomo“. Anselmo è uno dei pochi pensatori dell’età medioevale che lasci note personali alle proprie opere, alle quali era legato da un attaccamento quasi museale (addirittura suddivide egli stesso i suoi scritti in capitoli).
E’ originario di Aosta, ma ben presto si spinge fino in Borgogna, dove riceve notizie dell’abate del Bec (piccolo paese nell’attuale Normandia), Lanfranco di Pavia (anch’egli italiano), e decide di trasferirsi colà. Improvvisamente Lanfranco è richiamato da Guglielmo il conquistatore, che lo vuole vescovo di Canterbury: sarà Anselmo a prendere il suo posto una volta che Lanfranco morirà, rivelando però (a differenza di Lanfranco) una personalità schiva e avversa ai compromessi e, in forza di ciò, entrerà in conflitto col re d’Inghilterra, che arriverà ad esiliarlo (il papa interverrà in merito solo tiepidamente).
L’intera produzione anselmiana risale tuttavia al suo soggiorno nel Bec, quando il filosofo aostano era immerso nella quiete del monastero. Gli interessi di Anselmo orbitano soprattutto (ma non solo) intorno alla questione dell’esistenza di Dio, ch’egli prova a dimostrare percorrendo due diverse vie: la prima – intrapresa nel Monologion – è quella che sarà detta “a posteriori”, poiché parte dagli effetti, ossia dagli enti che popolano il mondo sensibile e cadono continuamente sotto i nostri sensi, per risalire a ciò che li ha causati (Dio). Nel Proslogion, invece, egli imbocca una strada alternativa, radicalmente nuova rispetto a tutta la tradizione occidentale: si tratta della celebre “prova ontologica”, con la quale Anselmo dimostra l’esistenza di Dio lavorando esclusivamente sul concetto stesso di Dio. Pur dichiarando egli di partire da null’altro all’infuori della ragione, il punto di partenza di Anselmo é la fede nella verità rivelata da Dio e contenuta nelle Sacre Scritture: ad esse, che costituiscono l’auctoritas per eccellenza, si affiancano gli insegnamenti dei Padri della Chiesa.
Il programma di Anselmo é compendiabile nel detto credo ut intelligam (“credo per comprendere”), il suo intento é di approfondire le ragioni (intelligere) che sono presenti nei contenuti della fede , nella misura in cui ciò é possibile nella condizione terrena . La comprensione , però , non é veramente possibile se non si ha la fede ; ragione e fede non sono dunque due ambiti separati o addirittura contrastanti , nè esiste una distinzione fra teologia e filosofia.
Anselmo è uno dei maggiori pensatori del Medioevo, che ha influenzato in maniera significativa la teologia scolastica successiva. Le sue opere e i suoi argomenti sulla prova dell’esistenza di Dio, sull’incarnazione di Cristo e sulla redenzione hanno aperto la strada a numerose discussioni nella filosofia cristiana medievale. Anselmo rimane una figura centrale del pensiero filosofico, teologico e religioso medievale.
Testimonianza della grande fortuna che arrise ad Anselmo è il fatto che Dante lo collochi nel “Paradiso” (Paradiso, XIII, 130-138):
Illuminato ed Agositin son quici,
Che fur de’primi scalzi poverelli,
Che nel capestro a Dio si fêro amici.
Ugo da Sanvittore è qui con elli,
E Pietro Mangiadore, e Pietro Ispano,
Lo qual giù luce in dodici libelli;
Natan Profeta, e’l metropolitano
Crisostomo ed Anselmo e quel Donato,
Ch’alla prim’arte degnò por la mano.
Monologion
Nel proemio del Monologion scrive Anselmo: “alcuni confratelli mi pregarono ripetutamente di scrivere per loro come esempio di meditazione le cose che avevo loro esposto circa Dio con linguaggio ordinario”. L’opera è dunque una rielaborazione di discorsi tenuti da Anselmo coi suoi confratelli del monastero e, leggendola, si nota come egli non lasci alcuna questione in sospeso, ma risponda a tutte le possibili obiezioni degli interlocutori. Egli si propone di non ricorrere all’ausilio delle attestazioni della rivelazione, ma di limitarsi all’uso della ragione, arrivando in tal senso a trovare in essa una luce in grado di rischiarare gli atti di fede e le Verità rivelate, “e tutto ciò con stile piano e argomenti accessibili a tutti”, senza trascurare anche le più semplici e sciocche obiezioni. Come Anselmo stesso racconta nel proemio, in un primo momento rifiutò di comporre l’opera, nonostante le assillanti richieste dei suoi confratelli, adducendo anche futili scuse (quali quella di non essere all’altezza del lavoro), ma alla fine, seppur controvoglia per via della difficoltà dell’argomento e – a suo dire – della debolezza del suo ingegno, accetta l’impresa, convinto che lo scritto sarebbe circolato esclusivamente all’interno del monastero, senza prevedere che in realtà ben preso si sarebbe diffuso per l’intera Europa, con un successo editoriale straordinario (addirittura c’era gente che lo imparava a memoria). Rileggendo lo scritto, Anselmo nota l’impressionante vicinanza del suo pensiero con quello di Agostino, e quando Lanfranco lo accusa per via epistolare di aver fatto troppo affidamento sulla ragione, egli ribatte che si è limitato a reinterpretare il “De Trinitate” agostiniano in chiave razionale, arrivando con l’uso della ragione alle stesse Verità attestate dalla Rivelazione; in particolare, egli noterà come la Trinità, da lui intesa nello scritto come “tre sostanze” (e non “tre persone”, secondo la Rivelazione), è concepita in piena sintonia con gli insegnamenti dei Padri greci, ad avviso dei quali sostanza è effettivamente sinonimo di persona (viene così scongiurato ogni possibile equivoco). Come abbiamo detto, nel “Monologion” ci imbattiamo in una dimostrazione “a posteriori” dell’esistenza di Dio, un’argomentazione che si articola in tre punti ben distinti: il punto di partenza da cui Anselmo muove è il mondo sensibile, nella sua datità e nella sua inevitabile inspiegabilità; l’unica strategia per render conto di esso è far riferimento ad un ente (Dio appunto) che, con una creazione “ex nihilo”, l’abbia creato; anche se il termine “ex nihilo” desta non pochi problemi, sui quali Anselmo si sofferma minuziosamente, nel tentativo di dissiparli. Dopo questo avvio, egli giunge, a poco a poco, a parlare della Trinità e così, dopo aver seguito i sentieri tracciati dalla ragione, può finalmente dare libero sfogo alla sua fede. Nel capitolo I dell’opera egli scrive – in toni fortemente platonico/agostiniani -, a conclusione del suo argomentare: “vi è un ente ottimo e massimo e più alto di tutto quel che esiste”. Il punto d’arrivo della prima delle tre prove dispiegate è dunque la dimostrazione dell’esistenza di un ente ottimo e massimo, partendo dalla nozione stessa di bontà, insita nelle nostre menti. Facciamo esperienza di tale nozione – nota Anselmo – nella misura in cui, nella vita di tutti i giorni, abbiamo a che fare con cose buone, sicchè riscontriamo tale concetto nelle entità empiriche. Come si può spiegare l’esistenza di quelle cose buone a cui tutti, per natura, tendiamo? Non si dovrà forse ammettere l’esistenza di qualcosa in virtù di cui esse sono buone? Come è facile capire, il procedere anselmiano è assolutamente razionale, a tal punto che anche chi ignora l’esistenza di Dio può arrivare a comprenderla avvalendosi della sola ragione, e se non riesce a capirlo, ciò significa che non è un uomo, ma una bestia sprovvista di ragione. Anselmo, per sua stessa ammissione, sostiene di non poter dimostrare la necessità di Dio (e in merito al concetto di “necessità” egli aveva letto alcuni scritti logici di Aristotele), ma si accontenta che ciò abbia una probabilità, ovvero che sia ragionevole ritenere che Dio esista. Tuttavia, egli muove obiezioni e critiche alla sua stessa argomentazione: preso atto dell’esistenza di “cose” buone, ne deriva che dovrà sussistere un’entità in forza della quale tali cose sono, appunto, buone; ma che cosa mi vieta di pensare che non si tratti di un’entità, ma di una pluralità di entità? Chi mi vieta di pensare che a render buone le cose sia non un ente unico, ma più enti, dei quali qualcuno rende buone certe cose, qualcun altro ne rende buone altre? Tuttavia – risponde Anselmo – quando istituiamo una gerarchia, è chiaro che lo facciamo sempre in base ad un’unica pietra di paragone, ovvero facendo riferimento ad una sola realtà in base alla quale diciamo che le cose sono giuste, buone, belle: ad esempio, le cose giuste sono dette tali in base ad un unico metro di misura, la giustizia. Facendo ricorso al linguaggio ordinario (proprio come era solito fare Agostino), Anselmo arriva significativamente a chiedersi: perché diciamo che un cavallo è buono quando è forte e veloce (ossia quando ci è utile), ma non diciamo altrettanto di un ladro forte e veloce? Quel qualcosa è buono intrinsecamente o solo per l’utilità che noi ne traiamo? Il pensatore di Aosta risponde che le cose sono buone poiché sussiste un’entità che le rende tali, ed è anzi facendo costante riferimento a tale entità che predichiamo la bontà di quelle cose. Similmente, Tommaso d’Aquino, con la sua quarta prova argomentativa in favore di Dio (una prova di sapore platonico/avicenniano), dirà che se c’è una scala di valori, allora dovrà esserci il minimo e il massimo di tale scala, il che implica l’esistenza di Dio come vertice della gerarchia. Ma, in fin dei conti, la prova può essere in questo modo se non distrutta, almeno fatta scricchiolare: se c’è una gradualità, allora c’è un’unità di misura, ma non necessariamente un massimo e un minimo. Dopo aver trattato nel capitolo II lo stesso argomento del capitolo I come corollario, nelle due parti successive Anselmo parla della “natura”, intesa non aristotelicamente, ma nel mero significato di “essenza”. Se esiste una natura – argomenta Anselmo -, allora dovrà per forza sussistere un ente incausato da cui essa deriva: “tutto ciò che è, esiste in virtù di un unico ente”; le cose, infatti, o esistono in forza di qualcosa o in forza del nulla, il che però è evidentemente assurdo e contraddittorio. Ne consegue, allora, che le cose derivano da qualcosa (e non dal nulla): ma questo qualcosa è un ente singolo o, piuttosto, una molteplicità di enti? Nel caso in cui fosse un ente molteplice, occorrerebbe spiegare se ciascuno di tali enti sussista autonomamente o invece se alcuni siano causati da altri; ma in questo secondo caso, essendo alcuni enti causati da altri, si ritornerebbe al punto di partenza, a dover ammettere un ente da cui tutti gli altri derivano. Se invece ciascun ente esiste indipendentemente dagli altri, ciò avviene necessariamente grazie ad una forza che lo consenta. Ma tale forza, allora, sarà la stessa in tutti gli enti, e dunque sarà essa il principio unico da cui tutto deriva. In ogni caso, pertanto, si è condannati allo scacco: l’ente da cui la natura deriva è unitario, e corrisponde a Dio. Sarebbe inutile, in questa prospettiva, tentare di spiegare le cose ipotizzando una loro azione reciproca e circolare, così come invece può spiegarsi il rapporto tra servo e padrone: al contrario, poiché esiste un ente che fa sì che esistano tutte le altre cose nella loro indefinita molteplicità (e tale ente è Dio), esso sussiste autonomamente, senza però essere “causa sui”, perché altrimenti – nota Anselmo con straordinaria acutezza – in Dio vi sarebbe distinzione interna tra causa ed effetto, cosicchè ci si troverebbe assurdamente costretti ad ammettere la molteplicità di Dio. La terza prova addotta da Anselmo in difesa dell’esistenza di Dio poggia sui valori delle cose: se osserviamo la natura, ci accorgiamo facilmente di come essa sia popolata da cose non equiparabili, ma poste su piani differenti; così il cavallo è superiore rispetto alla pietra, e l’uomo lo è rispetto al cavallo, e così via. Chi non si accorgesse di ciò, sostiene Anselmo, sarebbe indegno di esser detto uomo, poiché rivelerebbe una totale assenza della ragione, che è appunto – aristotelicamente – ciò che qualifica la nostra essenza di esseri umani. Ora, ammettendo tale scala di valori (in base alla quale l’uomo sta sopra il cavallo, il quale a sua volta sta sopra la pietra), si andrebbe avanti all’infinito se non si ammettesse come vertice una natura eccelsa, a cui nulla sia superiore: ma una tale natura potrebbe essere unitaria o molteplice, e per dimostrare la sua unitarietà Anselmo fa ricorso alle argomentazioni dispiegate in precedenza. Tale natura eccelsa e unitaria corrisponde a Dio. Ed è importante notare come Anselmo, profondamente “realista” nelle sue convinzioni logiche (pensiamo alla disputa medioevale sui nomi), arriverà a dire che perfino lo stolto che nega l’esistenza di Dio deve necessariamente avere nella sua mente l’idea di Dio, e alle idee corrisponde sempre (o quasi) qualcosa di reale. Ritorna, in questo senso, la centralità dell’intelletto, di quella luce soffusa che ci fa riconoscere la Verità.
Proslogion
In quest’opera, Anselmo parte dalla pura concettualità per risalire all’esistenza: muovendo dalla mera nozione di Dio che ciascuno di noi ha nella sua mente, egli mostra come a ciò debba necessariamente corrispondere qualcosa di reale. Del resto, l’esigenza di dimostrare in modo certo e innovativo l’esistenza di Dio era per Anselmo diventata una vera ossessione che non gli dava pace e che non gli permetteva di pensare più a null’altro. Stando a quanto racconta il suo biografo, dopo un lungo arrovellarsi Anselmo ebbe finalmente – nel cuore della notte – un’illuminazione divina che gli fece balzare alla mente quella che dai suoi successori (parecchi secoli dopo) sarà detta “prova ontologica dell’esistenza di Dio”; ed è in seguito a tale illuminazione divina che egli decise di impugnare la penna e di comporre il “Proslogion”, nel cui proemio rivela che già parecchio tempo addietro “cominciai a chiedermi se non si potesse trovare un unico argomento possibile” per dimostrare che Dio è, e che di conseguenza è buono e dotato di tutte le altre qualità che gli sono proprie. A differenza che nel “Monologion” (dove il punto di partenza era la ragione indagatrice sul mondo empirico), ora Anselmo parte dalla fede e dalle sue verità, e si propone di “capire ciò che crede”; dal punto di vista della fede, egli non ha alcun dubbio, giacchè le verità di cui essa è portavoce sono indubitabili; si tratta, però, di impiegare l’intelletto per arrivare ad una comprensione razionale di tali verità, ed è per questo che Anselmo parla esplicitamente – sulle orme di Agostino – di “fides quaerens intellectum”, quasi convinto che, una volta risolto il problema dell’esistenza di Dio, ne derivino a cascata tutte le altre verità. Se il “Monologion” era un soliloquio, ovvero un dialogo con se stesso, alla maniera agostiniana dei “Soliloqui”, il “Proslogion” si configura invece come “colloquio” con Dio e con la propria anima, quasi come se Anselmo avesse avuto un’esperienza mistica (ed è questa la lettura che del “Proslogion” diede Karl Barth). Nei “Soliloqui” Agostino si rivolgeva alla propria anima, confidandole di voler conoscere lei e Dio stesso: Anselmo, invece, parte da una considerazione sull’affanno della situazione umana, immersa in una incessante corsa e nelle prime pagine dell’opera scrive: “orsù, omiciattolo, fuggi per un poco dalle tue occupazioni [.], dedicati per un poco a Dio e riposati in Lui”. Pur muovendo dalla constatazione dell’affannosità della vita umana, Anselmo non si abbandona a quel “contemptus mundi” (il “disprezzo del mondo”) che invece ritroviamo in molti altri Medievali. La prova ontologica viene sviluppata a partire dal libro II, il cui titolo suona “Dio esiste veramente”: il punto di partenza è – come abbiamo detto – il contenuto della fede, ed in particolare la definizione – a tutti evidente – che essa fornisce di Dio come “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” (“id, quo maius cogitari nequit”). Perfino lo stolto di cui parla la Bibbia dice sì in cuor suo che Dio non esiste, ma ne condivide la definizione con il credente: anche per lui Dio è “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”. Si può dunque dire che il concetto di Dio è presente nel suo intelletto, anche se egli è convinto che quel qualcosa non esista nella realtà. Si tratterà dunque – nota Anselmo – di passare dall’esistenza mentale (concettuosa) a quella reale: e per meglio compiere questo salto, il pensatore di Aosta ricorre all’esempio del pittore che, ancor prima di iniziare il quadro, ce l’ha già impresso nella propria mente (il monaco benedettino Gaunilone tuonerà contro Anselmo notando come siano fuori luoghi questi esempi: come possiamo accostare Dio ad un quadro? E poi: un quadro cade sotto i nostri sensi, mentre di Dio non possiamo mai fare esperienza). Anche lo stolto dovrà convincersi che nella sua mente è presente la nozione di Dio come “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”: ma Dio non può esistere esclusivamente come nozione, altrimenti sarebbe possibile pensare un’altra cosa “di cui nulla si può pensare di maggiore” ma che – a differenza di Dio come lo intende l’insipiente – esiste effettivamente nella realtà: in tal caso, questa cosa (che esiste oltre ad essere “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”) sarebbe maggiore rispetto a Dio (che esiste solo come nozione), e dunque si potrebbe pensare qualcosa di maggiore rispetto a “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”: il che è naturalmente contraddittorio. Infatti, ritenere che “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” non esista nella realtà significa privarlo di quel sommo grado dell’essere che è l’esistenza, ovvero vuol dire che non può essere “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”: “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore”, infatti, per essere davvero tale, deve avere, oltrechè ad un’essenza, anche l’esistenza. In età illuministica, Kant (fiero sostenitore dell’indimostrabilità dell’esistenza di Dio) dirà che non si può in alcun caso far derivare l’esistenza dall’essenza, adducendo l’esempio dei cento talleri pensati e dei cento talleri esistenti: Hegel biasimerà Kant rinfacciandogli che il suo è un ragionare barbarico, poiché non si può accostare Dio a cento talleri. Questa vivace diatriba sorta in età moderna intorno alla validità della prova ontologica, ai tempi di Anselmo era pressochè assente. Anzi, dopo che egli ebbe composto il “Proslogion” calò il silenzio nella cultura a lui contemporanea: solo nel XIII secolo a.C. si comincerà a discutere sulla prova ontologica; il caso del monaco Gaunilone, che non appena esce il “Proslogion”, lo attacca duramente, è un caso più unico che raro. Nel capitolo III del suo scritto, Anselmo chiarisce ulteriormente – ma senza apportare in realtà grandi innovazioni – perché Dio non possa non esistere, mentre nel IV spiega perché l’insipiente ha potuto credere che Dio non esistesse: qualunque cosa noi pronunciamo dentro di noi è pensiero, ma (stando agli insegnamenti del “De magistro” di Agostino) possiamo fermarci al puro segno (alla parola cui non corrisponde nulla di reale) o invece spingerci alla parola significante qualche cosa (così il termine “sedia” è un “signum” che significa qualche cosa di reale), con la conseguenza che secondo la prima modalità (che è propria dell’insipiente) si può dire che Dio non esista, ma attenendosi alla seconda ciò non è possibile. Alla prova ontologica anselmiana resteranno fedeli (oltre a Hegel) Bonaventura, Cartesio, Leibniz e – pare – perfino Bertrand Russell, il quale – uscito per comprare del tabacco – si arrovellava sull’argomento anselmiano fino a che, bloccatosi al centro della strada, non arrivò all’illuminazione che era una prova valida. Ma una lunga tradizione che parte da Gaunilone e giunge sino a Kant nega la validità della prova anselmiana: in particolare Gaunilone scrive un celebre “Liber pro insipiente” in cui si schiera al fianco dell’insipiente e contro Anselmo; in realtà il monaco benedettino ha una certa tendenza a strumentalizzare il pensiero anselmiano, come quando riferisce che, secondo Anselmo, qualsiasi cosa reale è maggiore di Dio come semplice concetto. Gaunilone (che è cristiano, e dunque saldamente convinto che Dio esista: critica la prova anselmiana, non l’esistenza di Dio in quanto tale) obietta al suo rivale che se ogni cosa pensata ha una sua corrispondenza nel reale, allora anche la chimera o il cavallo alato dovranno trovarvi posto. Se poi Dio è così evidente come Anselmo lo predica, che necessità c’era di costruire quel laborioso edificio che è la prova ontologica? Ma non solo: l’equazione anselmiana secondo cui il pensato è esistente deve essere argomentata, cosa che Anselmo non si preoccupa affatto di fare, ma dà per scontata. Ancora: come si può proclamare con tanta certezza che esista nella realtà quella cosa pensata che è Dio se non se ne è mai avuta esperienza? Oltre a queste riflessioni – nel loro insieme piuttosto acute – Gaunilone ne fa una che si rivela il suo grande passo falso, a tal punto che Anselmo – quando gli risponderà – farà leva quasi esclusivamente su di essa: se “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” deve per forza esistere, allora anche l’isola perfetta – e così il perfetto per ogni categoria (il cavallo perfetto, l’uomo perfetto, ecc) – dovrà necessariamente esistere. Anselmo compone un libro di risposta alle critiche gauniloniane (“Liber apologeticus”), in cui, giustamente, critica duramente il suo avversario per aver paragonato Dio ad un’isola. E, poiché si tratta di rispondere al cattolico Gaunilone e non all’insipiente ateo, Anselmo fa costante riferimento all’idea di Dio (e alle sue conseguenze) derivata dalla fede: dicendo che non vale l’argomentazione secondo cui “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” deve per forza esistere, si va contro la fede, il che è inammissibile. A Parigi, nel XIII secolo, fiorisce un dinamico dibattito intorno alla prova anselmiana: Alessandro di Hales non esita a condividerla, e pure Tommaso d’Aquino ne fa esplicita menzione, pur senza citare Anselmo. L’Aquinate, ne “La somma teologica”, sviluppa la sua analisi in tre punti essenziali: a) come nota Damasceno, “omnibus cognitio existendi Deum naturaliter est inserta” (“la conoscenza dell’esistenza di Dio è in tutti naturalmente insita”); b) inteso che cosa significa Dio, si capisce all’istante ch’Egli esiste, perché, essendo “ciò di cui nulla si può pensare di maggiore” (e qui vi è un’eco anselmiana), deve esistere sia come concetto sia come ente reale; c) è evidente che la verità esista, poiché anche chi la nega incappa in una Verità (la verità che non ci sono verità): ma la verità esiste solo se c’è una Verità, e tale è Dio secondo i Testi Sacri.