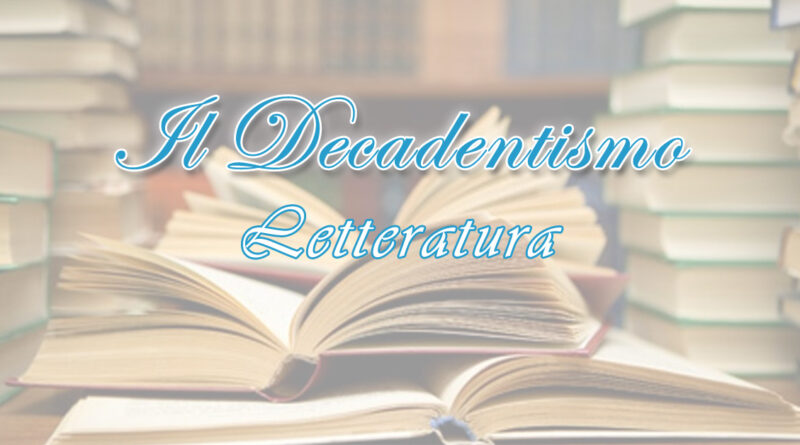Giovanni Pascoli
Giovanni Pascoli nacque a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855. Da ragazzo fu nel collegio dei Padri Scolopi ad Urbino, quindi nei licei di Rimini e di Firenze. Nel 1867, il padre, mentre tornava a casa su un calessino trainato da una cavalla storna, rievocata in una poesia, fu ucciso. Non si seppe mai chi fosse l’assassino ed il delitto rimase perciò impunito. Poco dopo la morte del padre il Pascoli perse anche la madre e le due sorelle: e la famiglia, composta prevalentemente di ragazzi, cadde nella miseria e nel dolore. Il poeta poté giungere alla laurea, grazie ad una borsa di studio che gli permise di frequentare l’università di Bologna. Su questo fatto importante egli ha lasciato una commossa rievocazione nel racconto (quando adulto, molti anni dopo, il 9 febbraio 1896, Pascoli lo pubblicò su “Il Resto del Carlino”, come benvenuto mentre Bologna festeggiava il Carducci per il suo il trigesimo quinto anniversario dell’insegnamento in quell’ Univérsità): “Ricordi di un vecchio scolaro”.
Certamente le vicende tristissime della sua famiglia, a cui egli assistette da fanciullo, e poi le difficoltà economiche e gli ostacoli da superare, sempre solo, lasciarono un solco profondo nel suo animo ed influirono sul suo carattere e conseguentemente sulla sua poesia.
Da professore insegnò a Matera e quindi a Massa ed a Livorno, ma, avendo assunto atteggiamenti anarchici, fu trasferito a Messina. Ma non fu un ribelle, anzi, alla maniera decadente si chiuse nel suo dolore, si isolò in se stesso, solo con le sue memorie e con i suoi morti. La sua ribellione fu un senso di ripulsa e di avversione per una società in cui era possibile uccidere impunemente e nella quale si permetteva che una famiglia di ragazzi vivesse nella sofferenza e nella miseria.
Non c’è ribellione nella sua poesia, ma rassegnazione al male, una certa passività di fronte ad esso: vi domina una malinconia diffusa nella quale il poeta immerge tutto: uomini e cose. Egli accetta la realtà triste come è, e si sottomette al mistero che non riesce a spiegare. La sua poesia non ha una trama narrativa e non è neppure descrittiva: esprime soltanto degli stati d’animo, delle meditazioni. E’ l’ascolto della sua anima e delle voci misteriose che gli giungono da lontano: dalla natura o dai morti.
LA VITA
| 1855 | Nasce, quarto figlio, da Ruggero e da Caterina Allocatelli Vincenzi. |
| 1861-71 | Studia nel collegio dei padri scolopi a Urbino. |
| 1867 | Il padre viene assassinato mentre torna a casa in calesse. |
| 1868 | Muore la madre |
| 1871-73 | Frequenta il liceo a Rimini. |
| 1873 | Vince una borsa di studio – lo esamina Carducci – e si iscrive alla facoltà di lettere dell’Università di Bologna. |
| 1876-77 | Anni di miseria perché ha perso la borsa di studio; trascura gli studi, frequenta l’anarchico Andrea Costa, si impegna in riunioni e attività politiche. Si iscrive all’Internazionale Socialista di Bologna |
| 1879 | Nel settembre viene arrestato per aver partecipato ad una dimostrazione di anarchici ma viene prosciolto in dicembre. |
| 1882 | Si laurea in greco e con l’interessamento di Carducci ottiene un posto al liceo di Matera. |
| 1884 | È trasferito al liceo di Massa, dove qualche anno dopo chiama a vivere presso di sé le sorelle Ida e Maria. |
| 1891 | Prima edizione di Myricæ . |
| 1892 | Vince la prima medaglia d’oro al concorso di poesia latina ad Amsterdam. |
| 1895 | Il matrimonio della sorella Ida lo sconvolge. Scrive alla sorella Maria da Roma, dove è “comandato” al Ministero della pubblica istruzione: “Questo è l’anno terribile, dell’anno terribile questo è il mese più terribile. Non sono sereno: sono disperato. Io amo disperatamente angosciosamente la mia famigliola che da tredici anni, virtualmente, mi sono fatta e che ora si disfà, per sempre. Io resto attaccato a voi, a voi due, a tutte e due: a volte sono preso da accesi furori d’ira, nel pensare che l’una freddamente se ne va strappandomi il cuore, se ne va lasciandomi mezzo morto in mezzo alla distruzione de’ miei interessi, della mia gloria, del mio avvenire, di tutto!” |
| 97-03 | Insegna letteratura latina all’Università di Messina, dove vive, ma ritorna spesso a Castelvecchio, presso Barga, dove ha affittato una casa di campagna che nel 1902 compra col ricavato dalla vendita di cinque medaglie d’oro conquistate al concorso di Amsterdam. |
| 1904 | Pubblica i Poemi conviviali e l’edizione definitiva dei Primi poemetti. |
| 1905 | Succede a Carducci nella cattedra di letteratura italiana all’Università di Bologna. |
| 1906 | Pubblica Odi ed Inni. |
| 1909 | Pubblica i Nuovi poemetti e le Canzoni di Re Enzio. |
| 1912 | Muore di cancro a Castelvecchio il 6 aprile |
OPERE PRINCIPALI
1891 – Myricae (la fondamentale raccolta di versi esce nella I edizione)
1897 – Poemetti
1898 – Minerva oscura (studi danteschi)
1903 – Canti di Castelvecchio (dedicati alla madre)
– Myricae (edizione definitiva accresciuta)
– Miei scritti di varia umanità (di essi fa parte «Il Fanciullino»)
1904 – Primi poemetti
– Poemi conviviali
1906 – Odi e Inni
1907 – Canti di Castelvecchio (edizione definitiva)
– Pensieri e discorsi
1909 – Nuovi poemetti
– Poemi italici
1911/12 – Poemi del Risorgimento
– La grande proletaria si è mossa.
IL PENSIERO DI PASCOLI
Pascoli ebbe una concezione dolorosa della vita, sulla quale influirono due fatti principali: la tragedia familiare e la crisi di fine ottocento.
La tragedia familiare colpì il poeta quando il 10 agosto del 1867 gli fu ucciso il padre. Alla morte del padre seguirono quella della madre, della sorella maggiore, Margherita, e dei fratelli Luigi e Giacomo. Questi lutti lasciarono nel suo animo un’impressione profonda e gli ispirarono il mito del “nido” familiare da ricostruire, del quale fanno parte i vivi e idealmente i morti, legati ai vivi dai fili di una misteriosa presenza. In una società sconvolta dalla violenza e in una condizione umana di dolore e di angoscia esistenziale, la casa è il rifugio nel quale i dolori e le ansie si placano.
L’altro elemento che influenzò il pensiero di Pascoli, fu la crisi che si verificò verso la fine dell’Ottocento e travolse i suoi miti più celebrati, a cominciare dalla scienza liberatrice e dal mito del progresso. Pascoli, nonostante fosse un seguace delle dottrine positivistiche, non solo riconobbe l’impotenza della scienza nella risoluzione dei problemi umani e sociali, ma l’accusò anche di aver reso più infelice l’uomo, distruggendogli la fede in Dio e nell’immortalità dell’anima, che erano stati per secoli il suo conforto:
…tu sei fallita, o scienza: ed è bene: ma sii maledetta che hai rischiato di far fallire l’altra. La felicità tu non l’hai data e non la potevi dare: ebbene, se non hai distrutta, hai attenuata oscurata amareggiata quella che ci dava la fede…
Pertanto, perduta la fede nella forza liberatrice della scienza, Pascoli fa oggetto della sua mediazione proprio ciò che il positivismo aveva rifiutato di indagare, il mondo che sta al di là della realtà fenomenica, il mondo dell’ignoto e dell’infinito, il problema dell’angoscia dell’uomo, del significato e del fine della vita.
Egli però conclude che tutto il mistero nell’universo è che gli uomini sono creature fragili ed effimere, soggette al dolore e alla morte, vittime di un destino oscuro ed imperscrutabile. Pertanto esorta gli uomini a bandire, nei loro rapporti, l’egoismo, la violenza, la guerra, ad unirsi e ad amarsi come fratelli nell’ambito della famiglia, della nazione e dell’umanità. Soltanto con la solidarietà e la comprensione reciproca gli uomini possono vincere il male e il destino di dolore che incombe su di essi.
La condizione umana è rappresentata simbolicamente dal Pascoli nella poesia I due fanciulli, in cui si parla di due fratellini, che, dopo essersi picchiati, messi a letto dalla madre, nel buio che li avvolge, simbolo del mistero, dimenticano l’odio che li aveva divisi e aizzati l’uno contro l’altro, e si abbracciano trovando l’uno nell’altro un senso di conforto e di protezione, sicchè la madre, quando torna nella stanza, li vede dormire l’uno accanto all’altro e rincalza il letto con un sorriso.
OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE
Pascoli usa ancora forme classiche come il sonetto, gli endecasillabi o le terzine, ma la sua poesia costituì la prima reale rottura con la tradizione. Al di là della sua apparente semplicità, è dalla poesia di Pascoli che genera buona parte della poesia del Novecento. Le numerose pause che generano spezzature all’interno del verso, oppure le frequenti rime sdrucciole che producono accelerazione; l’uso insistito delle onomatopeee, la presenza di parole ricavate dalla lingua dei contadini così come da quella dei colti, l’introduzione di temi fino ad allora rifiutati dai poeti importanti, tutto concorre a produrre una poesia che è rivoluzionaria nella sostanza e nelle intenzioni più che nella forma esteriore.
Il poeta è, per Pascoli, colui che è capace di ascoltare e dar voce alla sensibilità infantile che ognuno continua a portare dentro di sé pur diventando adulto. La poesia scopre nelle cose rapporti che non sono quelli logici della razionalità e attribuisce ad ogni cosa il suo nome. Essa, senza proporsi direttamente scopi umanitari e morali, porta ad abolire l’odio, a sentirsi tutti fratelli e a contentarsi di poco, come avviene nei fanciulli.
… io vorrei trasfondere in voi, nel modo rapido che si conviene alla poesia, qualche sentimento e pensiero mio non cattivo. […] Vorrei che pensaste con me che il mistero, nella vita, è grande, e che il meglio che ci sia da fare, è quello di stare stretti più che si possa agli altri, cui il medesimo mistero affanna e spaura. E vorrei invitarvi ala campagna.
(dalla Prefazione ai Primi poemetti, 1897)
Myricæ (1891): è una raccolta di liriche di argomento semplice e modesto, come dice lo stesso Pascoli, ispiratosi per lo più a temi familiari e campestri. Il titolo è dato dal nome latino delle tamerici (“non omnes arbusta iuvant humilesque Myricæ”: non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici), umili pianticelle che sono prese a simbolo di una poesia senza pretese, legata alle piccole cose quotidiane e agli affetti più intimi.
Il titolo è allusivo ad una poesia dimessa, diversa da quella del Carducci e anche da quella ardua e aristocratica di D’Annunzio. La prima edizione è del 1891. Insieme con i Canti di Castelvecchio sono opere che la critica ha definito “del Pascoli migliore”, poeta dell’impressionismo e del frammento: “Son frulli di uccelli, stormire di cipressi, lontano cantare di campane&”, scrisse il poeta nella Prefazione del 1894.
E’ dunque una poesia fatta di piccole cose, inerenti per lo più alla vita della campagna, di quadretti rapidissimi, conclusi nel giro di pochi versi “impressionistici”, dove le “cose” sono definite con esattezza, col loro nome proprio (per esempio prunalbo per biancospino). Vi compaiono anche poesie (Novembre, Arano) in cui le “cose” si caricano di una responsabilità simbolica e già si affaccia il tema dei morti (X Agosto), sottolineando una visione della vita che tende a corrodere i confini del reale -avvertito come paura e mistero- per una evasione nella fiaba e nel simbolo (Carrettiere, Orfano, L’assiuolo).
Nella raccolta, cresciuta nel tempo dalle 22 poesie della prima edizione alle 155 dell’ultima, tolti pochi componimenti rimasti a sé, le poesie si ordinano per temi, corrispondenti ai cicli annuali della vita in campagna. La raccolta si apre con Il giorno dei morti, il giorno in cui il poeta si reca al camposanto che “oggi ti vedo / tutto sempiterni / e crisantemi. A ogni croce roggia / pende come abbracciata una ghirlanda /donde gocciano lagrime di pioggia.” In questa giornata “Sazio ogni morto, di memorie, riposa.” Non tutti però. “Non i miei morti.”
Tempora
Un bubbolìo lontano…
Rosseggia l’orizzonte,
come affocato, a mare:
nero di pece, a monte,
stracci di nubi chiare:
tra il nero un casolare:
un’ala di gabbiano.
Canti di Castelvecchio (1903): nella raccolta sono compresi e approfonditi i temi di Myricæ ma ha particolare incidenza il tema del nido familiare e delle memorie autobiografiche e compaiono parecchi componimenti di impianto narrativo; finito il vagabondaggio per la campagna di Myricæ se ne inizia uno nuovo: ma ora è un viaggio attorno al suo giardino, entro i cancelli e entro il suo orto.
Il senso del mistero, connesso al dolore della vita e all’angoscia della morte, si traduce ora in una sorta di allucinazioni, nel ricordo dei morti (“Mi son seduto in una panchetta / come una volta…/ quanti anni fa? / Ella, come una volta s’è stretta sulla panchetta”, La tessitrice), ora nell’auscultazione di richiami impercettibili (“… mi chiamano le canapine / coi lunghi lor gemiti uguali”, Le rane), ora nello sconfinamento dei ricordi -suggeriti ad esempio dal suono delle campane- ai limiti del preconscio: “Mi sembrano canti di culla / che fanno ch’io tori com’era / Sentivo mia madre… poi nulla… / sul far della sera” (La mia sera). Sono trasalimenti dell’animo e simboli che però lievitano frequentemente da notazioni realistiche, espresse attraverso un discorso addirittura narrativo: “E s’aprono i fiori notturni, nell’ora che penso ai miei cari / Sono apparse in mezzo ai viburni / le farfalle crepuscolari” (Il gelsomino notturno). Si può dire che nei Canti sta il punto del massimo compenetrarsi tra i due aspetti della poesia pascoliana: il simbolo e la realtà.
La mia sera
Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle. Nei campi
c’è un breve gre gre di ranelle.
Le tremule foglie dei pioppi
trascorre una gioia leggera.
Nel giorno, che lampi! che scoppi!
Che pace, la sera! Si
devono aprire le stelle
nel cielo sì tenero e vivo.
Là, presso le allegre ranelle,
singhiozza monotono un rivo.
Di tutto quel cupo tumulto,
di tutta quell’aspra bufera,
non resta che un dolce singulto
nell’umida sera.
È, quella infinita tempesta,
finita in un rivo canoro.
Dei fulmini fragili restano
cirri di porpora e d’oro.
O stanco dolore, riposa!
La nube del giorno più nera
fu quella che vedo più rosa
nell’ultima sera.
Che voli di rondini intorno!
che gridi nell’aria serena!
La fame del povero giorno
prolunga la garrula cena.
La parte, sì piccola, i nidi
nel giorno non l’ebbero intera.
Né io… e che voli, che gridi,
mia limpida sera!
Don… Don… E mi dicono, Dormi!
mi cantano, Dormi! sussurrano,
Dormi! bisbigliano, Dormi!
là, voci di tenebra azzurra…
Mi sembrano canti di culla,
che fanno ch’io torni com’era…
sentivo mia madre… poi nulla…
sul far della sera.
Poemetti (pubblicati nel 1897 e poi sdoppiati in Primi poemetti, 1904 e Nuovi poemetti, 1909): costituiscono una vera e propria epica rurale sul modello delle Georgiche virgiliane: cantano, in terzine dantesche, l’amore di Rosa per il cacciatore Rigo, la vita contadina, il lavoro dei campi (La sementa, La piada, L’accestire).
Italy affronta il tema dell’emigrazione (anch’esso riflesso di quello del nido) dove il contrasto campagna-città, infanzia-maturità, spogliato delle sue connotazioni autobiografiche, si oggettiva nel contrasto tra la vita patriarcale che si svolge nella campagna nativa e quella febbrile della metropoli americana, tutta tesa ai “bisini” (“business” gli affari) e al successo. Il contrasto si risolve sul piano linguistico in un audace sperimentalismo.
A queste composizioni si intrecciano altre percorse da un simbolismo insistito, e talvolta esplicito (Il libro); si accampa quella che è stata definita “una poesia astrale”, aperta a “voragini misteriose di spazio, di buio e di fuoco” (La vertigine).
Il libro
Sopra il leggìo di quercia è nell’altana,
aperto, il libro. Quella quercia ancora
esercitata dalla tramontana
viveva nella sua selva sonora;
e quel libro era antico. Eccolo: aperto,
sembra che ascolti il tarlo che lavora.
E sembra ch’uno (donde mai? non, certo,
dal tremulo uscio, cui tentenna il vento
delle montagne e il vento del deserto,
sorti d’un tratto…) sia venuto, e lento
sfogli – se n’ode il crepitar leggiero –
le carte. E l’uomo non vedo io: lo sento,
invisibile, là, come il pensiero…
Poemi conviviali (1904): il loro titolo è tratto dalla rivista “Convivio” di Alfredo De Bosis, ma allude anche ai canti degli aedi ai conviti (Triste il convito senza canto). In endecasillabi sciolti, richiamano miti e figure del mondo classico, greco e romano (il mito dell’Ellade percorre come un filo rosso tutto l’Ottocento, da Foscolo a Leopardi, a Carducci, a D’Annunzio): ma la sensibilità decadente di Pascoli stravolge questi miti, fino a farne simboli della infelicità e del mistero, annullando -secondo un procedimento tipico che sottintende la fuga dalla realtà- i confini della storia, per assorbirla in una visione esistenziale: così Alessandro Magno, arrivato ai confini della terra, piange, perché non può più “guardare oltre, sognare” (Piange dall’occhio nero come morte / piange dall’occhio azzurro come il cielo, Alèxandros); così l’etera non è più la creatura splendente di bellezza e di vita della tradizione classica, ma è la donna affannata che, nell’Erebo, è circondata dalle larve dei figli non nati; e “l’odissea” di Ulisse conduce l’eroe non verso le fascinose plaghe del mito (Polifemo e le sirene sono illusorie costruzioni della fantasia), ma verso l’orrenda morte. Odi e Inni: contengono componimenti scritti a partire dal 1903. Pascoli qui assume il ruolo di poeta-vate e celebra gli eroi nazionali, le realizzazioni del lavoro e della tecnica, le grandi esplorazioni; Carmina: è la raccolta delle poesie latine di Pascoli pubblicate dalla sorella Maria; Il fanciullino; La grande proletaria (per la seconda vedi a fondo pagina)
LA POETICA
La poetica di Pascoli è espressa nella celebre prosa, Il fanciullino.
Questi ne sono i punti essenziali:
Vi è in tutti noi un fanciullo musico (il “sentimento poetico”) che fa sentire il suo tinnulo campanello d’argento nell’età infantile, quando egli confonde la sua voce con la nostra – non nell’età adulta quando la lotta per la vita ci impedisce di ascoltarlo (l’età veramente poetica è dunque quella dell’infanzia).
Infatti, è tipico del fanciullo vedere tutto con meraviglia, tutto come per la prima volta; scoprire la poesia nelle cose, nelle più grandi come nelle più umili, nei particolari che svelano la loro essenza, il loro sorriso e le loro lacrime (la poesia la si scopre dunque, non la si inventa).
Il fanciullino è quello che alla luce sogna o sembra di sognare ricordando cose non vedute mai; è colui che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi alle nuvole, alle stelle, che scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose, che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alle nostra ragione (la poesia dunque ha carattere non razionale, ma intuitivo e alogico).
Il sentimento poetico, che è di tutti, fa sentire gli uomini fratelli, pronti a deporre gli odi e le guerre, a corrersi incontro e ad abbracciarsi, per questo la poesia ha in sé, proprio in quanto poesia una suprema utilità morale e sociale. Non deve proporselo però, in quanto la poesia deve essere “pura”, non “applicata” a fini prefissati; il poeta è poeta, non oratore o predicatore, non filosofo, non storico, non maestro…. La poesia ha una funzione consolatoria: fa pago il pastore della sua capanna, il borghesuccio del suo appartamentino ammobiliato. E per questo il poeta è per natura socialista, o come si avrebbe a dire umano.
ELEMENTI DELLO STILE
Il linguaggio: Pascoli usa un linguaggio poetico lirico, con echi e risonanze melodiche ottenute talvolta con ripetizioni di parole e di espressioni cantilenanti, arricchite di rapide note impressionistiche e di frasi spesso ridotte all’essenziale. In questo egli prelude ai poeti del novecento.
Il lessico: è nuovo, con mescolanze di parole dotte e comuni ma sempre preciso e scrupolosamente scientifico quando nomina uccelli (cince, pettirossi, fringuelli, assiuoli…) o piante (viburni o biancospini, timo, gelsomini, tamerici…).
Realtà e simbolismo: egli ricerca ” nelle cose il loro sorriso”, la loro anima, il loro significato nascosto e simbolico. Ecco perché la sua poesia è sempre ricca di allusioni e di analogie simboliche.
La sintassi: preferisce periodi semplici, composti di una sola frase, o strutture paratattiche con frasi accostate mediante virgole o congiunzioni.
Aspetto metrico e fonico: partendo dalla metrica classica e tradizionale vi innesta forme e metri nuovi, adatti ad esprimere timbri e toni nascosti, assonanze e allusioni. Cura in particolare la magia dei suoni, la trama sonora, gli effetti musicali di onomatopee espressive e di pause improvvise.
Accorgimenti stilistici: molto curate le scelte espressive. Per rendere le immagini più vive e sintetiche, Pascoli ama talvolta eliminare congiunzioni e verbi (ellissi) o fare accostamenti nuovi trasformando aggettivi e verbi in sostantivi (un nero di nubi… il cullare del mare…). Ne risulta uno stile impressionistico e nuovo.
LA PICCOZZA
(Testo originale e integrale, novembre 1911)
(da Limpido Rivo, prose e poesie pubblicate dalla sorella Maria il 5 sett. 1912)
Ne LA PICCOZZA, iI poeta, con la brevità che s’addice alla poesia lirica, descrive la miseria, il pianto e l’abbandono tra cui comincia la sua via, che poi prosegue con coraggio e con ardore in mezzo alle più grandi difficoltà e ai più gravi pericoli. La via sale. Va per il monte. Solo, senza aiuto e senza guida, solo con la piccozza con la quale si scava man mano il passo nel ghiaccio. Ma non sale per discendere, ossia per avere plausi e onori. Egli vuole poi, se giunge in cima, restare e morire tra le aquile, augurandosi che dietro lui qualcun altro arrivi, e, guidato dalla rilucente piccozza che a lui sarà scivolata di mano, ma che sarà poco lontana, lo trovi tra l’alga rossa. L’alga rossa che si vede talvolta sugli alti monti e che fa parere la neve tutta insanguinata.
Da me !… Non quando m’avviai trepido
c’era una madre che nel mio zaino
ponesse due pani
per il solitario domani.
Per me non c’era bacio né lagrima,
né caro capo chino su l’omero
a lungo, né voce
pregante, né segno di croce.
Non c’eri ! E niuno vide che lacero
fuggivo gli occhi prossimi, subito,
o madre, accorato
che niuno m’avesse guardato.
Da me, da solo, solo e famelico,
per l’erta mossi rompendo ai triboli
i piedi e la mano,
piangendo, sì, forse, ma piano:
piangendo quando copriva il turbine
con il suo pianto grande il mio piccolo,
e quando il mio lutto
spariva nell’ombra del Tutto.
Ascesi senza mano che valida
mi sorreggesse, nè orme ch’ abili
io nuovo seguissi
su l’orlo d’ esanimi abissi.
Ascesi il monte senza lo strepito
delle compagne grida. Silenzio.
Ne’ cupi sconforti
non voce, che voci di morti.
Da me, da solo, solo con l’anima,
con la piccozza d’acciar ceruleo,
su lento, su anelo,
su sempre; spezzandoti, o gelo!
E salgo ancora, da me, facendomi
da une la scala, tacito, assiduo;
nel gelo che spezzo,
scavandomi il fine ed il mezzo.
Salgo; e non salgo, no, per discendere,
per udir crosci di mani, simili
a ghiaia che frangano,
io, io, che sentii la valanga;
ma per restare là dov è ottimo restar,
sul puro limpido culmine,
o uomini; in alto,
pur umile: è il monte ch’è alto;
ma per restare solo con l’ aquile,
ma per morire dove me placido
immerso nell’alga
vermiglia ritrovi chi salga:
e a me lo guidi, con baglior subito,
la mia piccozza d’acciar ceruleo,
che, al suolo a me scorsa,
riflette le stelle dell’Orsa.
IDEOLOGIA E POETICA
Pascoli si è formato fuori del Risorgimento, è cresciuto cioè in un periodo in cui alle contraddizioni della società borghese si stava cercando una soluzione nel socialismo emergente, che in Italia si presentava nella variante anarchica, mentre la grande borghesia, alleata con gli agrari del Sud, la cercava in un governo forte e reazionario.
Quando il Pascoli rinuncia alle idee del socialismo anarchico (politicamente impegnato), approda progressivamente alla convinzione che il mondo e la nuova società borghese sono dominati da forze negative troppo superiori per essere vinte. Al massimo -pensa il Pascoli- è possibile attenuare l’impatto di queste forze sugli uomini, mediante una sorta di socialismo umanistico e filantropico (nel senso che tutte le classi sociali devono trovare ai loro conflitti una relativa conciliazione, nella consapevolezza di sentirsi reciprocamente indispensabili), e mediante una sorta di patriottismo-nazionalistico, per il quale le classi oppresse hanno il diritto a un’espansione coloniale verso l’Africa e di conquistare le terre irredente del nord-Italia, al fine di dimostrare le loro grandi capacità lavorative e civilizzatrici: in tal modo il Pascoli sperava di attenuare le forti tensioni sociali che erano scoppiate in tutta la nazione. Il suo discorso La grande proletaria, pronunciato nel 1911, al tempo dell’impresa libica, destò grandi entusiasmi nella stampa e nei teatri.
Il Pascoli eredita chiaramente la fine delle illusioni del secondo Ottocento nelle capacità della scienza-tecnica-industrializzazione di superare il dolore, la sofferenza, le contraddizioni degli uomini. Tutte queste cose non hanno tolto ma hanno anche creato nuovi dolori (la scienza -per il Pascoli- è solo servita a togliere le illusioni della religione). Il male, per lui, non è generato dalla natura (che anzi è “madre dolcissima”) ma dall’uomo sociale (ritenuto assai diverso dall’uomo primitivo, “buono per natura”).
Unico rimedio al male consiste nel fuggire tutto ciò che è prodotto di civiltà, rifugiandosi nel puro sentimento, nella solitudine, in un contatto più stretto con la natura, vista esteticamente ma anche come fonte di consolazione, come luogo simbolico in cui poter rievocare un passato, un’innocenza perduta definitivamente.
La natura è anche un luogo in cui si può meditare sul problema del dolore, della morte, della sofferenza degli uomini in maniera distaccata, cioè senza cercare nel conflitto delle classi una soluzione alle contraddizioni sociali. La meditazione sul dolore e sul mistero di una vita che ci fa nascere felici e ci fa diventare infelici, deve portare l’uomo ad avere pietà del suo simile. Il dolore infatti ha qualcosa di sacro e di necessario e per renderlo più sopportabile occorre la fraternità universale. Quella del Pascoli viene chiamata “poetica decadentistica della consolazione”.
Egli però definì la propria poetica con l’espressione “poetica del fanciullino”. Il poeta cioè è un fanciullo che sogna e vede cose che gli altri non vedono né possono vedere, essendo abituati ai nessi logici, razionali delle cose. Il “fanciullino” privilegia l’intuizione alla ragione, il sogno al vero, l’invenzione alla riproduzione, l’arbitrarietà della parola alla normalità comunicativa (grandissimo, in questo senso, fu il contributo stilistico del Pascoli).
Ricordi di un vecchio scolaro
(Testo integrale e letterale tratto da Limpido Rivo, prose e poesie pubblicate dalla sorella Maria il 5 sett. 1912)
Nota riportata dalla sorella Maria nello stesso volume:
“Questo scrittarello fu stampato nel giornale bolognese ” Il Resto del Carlino, la domenica 9 febbraio 1896, nel qual giorno si celebrava in Bologna solennemente il trigesimo quinto anniversario dell’insegnamento di Giosué Carducci in quell’ Univérsità. Il maestro vedendo quella mattina il vecchio scolaro, dopo la festa ineffabilmente soave e grande, gli disse: “Ho letto il tuo scritto: m’ha fatto piangere: tutto vero! tutto vero!”.
Lo “scrittarello”: RICORDI DI UN VECCHIO SCOLARO
” Il vecchio scolaro era allora un povero ragazzo smilzo e scialbo. Veniva dalla Romagna, da una casuccia dove una famiglia di ragazzi; di ragazzi e bambine soli soli, fatti orfani da un delitto tuttora impunito, e poi abbandonati e lasciati soffrire soli soli (era indifferenza della gente? era viltà?); una famiglia che aveva per capo il ragazzo più grande, sedicenne appena quando ebbe tutta la nidiata da imboccare; faceva economia.
Il ragazzo più grande (ora non vede e non sente più nulla, di là dove da un pezzo dimora, tra Savignano e San Mauro, a mezza strada, (Nota del Pascoli: A mezza strada tra San Mauro di Romagna é Savignano è il camposanto comune delle due terre. Quel fratello maggiore, di grande ingegno, di grandissimo cuore e di nessuna fortuna, si chiamava Giacomo é morì il 12 maggio del 1876. Infelice! Lasciò due bimbi ché morirono anche loro).
Non c’è più di lui ché la benedetta memoria! il ragazzo che faceva da babbo, credeva di scorgere in uno dei suoi figliuoli fratelli una certa disposizione alle lettere. Poi, in quell’anno, era bandito per la prima volta il concorso a sei sussidi per chi studiasse lettere nell’università di Bologna. Era una liberalità di questo Comune, di questa nobile città, liberalità vera e larga in quanto ammetteva al concorso tutti gli italiani, non i bolognesi soli: sicchè anche dall’umile villaggio della Romagna, dove era quella casuccia nella quale faceva economia quella famigliuola tutta di ragazzi e di bambine, il ragazzo più grande udì il buon invito fornì il suo minore (il vecchio scolaro: oh! dolcezza amara di ricordi !) di poche lire, troppe per chi le dava, un po’ pochine per chi le riceveva; lo imbarcò solo soletto in una terza classe del treno e gli disse: Tuo babbo ti aiuti! Era il giorno avanti il primo esame. La mattina dopo, il povero ragazzo smilzo e scialbo si trovava tra una ventina d’altri ragazzi, venuti da tutte le parti d’Italia, o sorridenti o rumorosi, aspettando… Aspettando chi? Carducci. Egli doveva venire a dettare il tema d’italiano. Proprio Carducci? Carducci in persona.
Oh ! il povero ragazzo aspettava con forse il maggior palpito. Egli non aveva nel suo ingegno e nei suoi studi la fede che aveva il suo fratello maggiore; egli prevedeva, ahimè ! di doversene tornare a casa, di lì a pochi giorni, come era venuto… cioè non come era venuto, ma senza quelle lire, o troppe o troppo poche; e trovare più freddo il freddo focolare quando si fosse spenta quell’ultima speranza. Ma non per questo palpitava, allora, il ragazzo, egli palpitava per l’aspettazione di colui che doveva apparire tra pochi minuti.
Nel collegio, donde era uscito anni prima (un ottimo collegio di scolopi), egli aveva sentito parlare di Carducci; come, si può immaginare: aveva cantato Satana! (Nota del Pascoli: Satana nell’inno del Carducci rappresenta il progresso, che si avanza sempre vincendo qualche pregiudizio che lo inimica; non il principio del male. Cambiando il nome di quello a cui è diretto, l’inno non avrebbe nulla di satanico).
Un bel giorno però uno degli scolopi, il professore d’italiano, ingegno elegante e ardito, anima e fiera e gentile, il Padre Donati (Nota del Pascoli: Padre Donati: era stato ed era tuttavia amico del Carducci, come del Néncioni e del Targioni Tozzetti; insomma di quelli che da sè si chiamavano “amici pedanti”. Nei loro conversari era detto “Cecco frate”. Era efficacissimo maestro, e puro e nervoso scrittore; un cinquecentista sperso nel secolo nostro) nella sua cella gli mostrò un ritratto : un ritratto di giovane avventuriere, cospiratore, soldato o che so io; una testa pugnace, audace di ribelle indomabile. Il ragazzo pensò forse a un prigione di Aspromonte, a un caduto di Mentana. ” Questo …disse il frate, ” è il poeta più classico e più novatore, lo scrittore più antico e più moderno che abbia l’Italia, è il Carducci. Al frate lucevano gli occhi azzurrissimi, e al ragazzo si cominciò a colorir l’anima di non so qual colore nuovo. Ricordò; e lesse poi quel che potè: ben poco; pure assai perchè nel momento che ho detto, egli palpitasse come forse non altri.
A un tratto un gran fremito, un gran bisbiglio: poi, silenzio. Egli era in mezzo alla sala, passeggiando irrequieto, quasi impaziente. Si volgeva qua e là a scatti, fissando or su questo or su quello, per un attimo, un piccolo raggio ardente de’ suoi occhi mobilissimi.
“L’opera di Alessandro Manzoni” dettò. Poi aggiunse con parole rapide, staccate, punteggiate: “Ordine, chiarezza, semplicità i Non mi facciano un trattato d’estetica”. Una pausa di tre secondi; e concluse: “Già non saprebbero fare”. Sorrise a questo punto? Chi lo sa? S’indugiò ancora un poco e uscì.
Oh ! il povero ragazzo stette più d’ un’ ora senza nemmeno provarsi a intingere la penna! Il suo vicino, un bel fanciullone piemontese, con una sua grossa e buona testa dondolante, gli domandò con gentile atto di pietà Non scrive? L’altro si svegliò dal suo torpore e cominciò a scrivucchiare. Che cosa, Dio mio? O piccolo padre lontano ! o dolci bambine preganti a quell’ora per lui ! È fatta: nella testa non c’è nulla di buono; nel calamaio, qualche paroletta a quando a quando. E questa ragnata tessitura di grame parole l’avrà a leggere lui? Avanti avanti ! come spinto a furia, per le spalle, inertemente !
E qualche giorno dopo ci fu l’esame orale. E il giovinetto romagnolo entrò avanti il consesso giudicante, come se vi fosse travolto da una ventata; e rivide lui e si sentì interrogare. Ma egli qualche cosa doveva aver letto nel viso smunto e pallido del ragazzo: leggeva forse il pensiero che appariva tra uno sforzo e un altro per rispondere; pensiero d’assenti, pensiero di solo al mondo, pensiero d’un dolore e d’una desolazione che al maestro non potevano essere fatti noti se non dagli occhi del ragazzo, che pregava forse con essi più che non rispondesse con la bocca; dagli occhi di lui soli, perchè nessuno aveva parlato o pregato per lui : certo il Maestro interrogava con non so qual pietà e ascoltava le risposte impacciate con una specie di rassegnazione cortese, accomodandole e spiegandole e giustificandole.
Passò questo doloroso quarto d’ora; passarono gli altri. Il ragazzo fu richiamato a dare qualche schiarimento sul suo attestato di licenza, sentì o credè sentire che il Carducci, proprio il Carducci, ampliava e chiariva le sue spiegazioni, comunicandole agli altri professori.
Questo lo sollevò un poco; ma ogni barlume di speranza era spento quando due o tre giorni dopo aspettava nell’università la sentenza che doveva essere Iì per li fatta pubblica dagli esaminatori. Egli si vergognava al pensiero che altri credesse che egli sperasse ancora e fosse lì per un’ ultima pertinace illusione. No no: egli era ben certo di non essere de’ sei primi: tutto al più sarebbe giudicato degno dell’ammissione (Nota del Pascoli: A quei tempi la legge era così, la licenza liceale non bastava, come basta ora, per entrare nell’università. Ci voleva un altro esame)
Ma per lui era lo stesso che esserne giudicato indegno: perchè senza il sussidio doveva tornarsene a casa e lasciarsi… vivere o morire? O vivere o morire, era lo stesso per lui. E dei buoni giovani gli facevano coraggio: Sono sei posti… Chi sa? Basta: a uno squillo di campanello tutti entrarono. Gli esaminatori erano tutti lì: la fiera testa del poeta si volgeva da parte, come indifferente.
Gandino, il severo e sereno Gandino, con quel volto che sembra preso a una medaglia romana, scandendo le parole con la sua voce armoniosa, ammonì: “Leggerò i nomi dei candidati secondo l’ordine di merito: i primi sei s’intende che hanno conseguito il sussidio comunale”. Pausa.
Al ragazzo romagnolo batteva il cuore; ma solo, per così dire, in anticipazione del palpito che lo avrebbe scosso in quel momento che era per separare il quinto nome dal sesto. Sonò il primo nome nel silenzio della sala… Era il suo. In quell’attimo egli, il povero ragazzo, vide lampeggiare un sorriso. Si: la testa del poeta si era illuminata d’un sorriso subito spento.
Oh ! il povero ragazzo è diventato un vecchio scolaro e potrà divenire un vecchio, senz’altro: si è trovato ad altre traversie, ha provato altre gioie, sebbene rare, ad altre si troverà, altre ne proverà, come vorrà il suo destino; ma non ha dimenticato e non dimenticherà mai quel sorriso! Egli senti poi il Carducci risuscitare e rievocare dalla cattedra le morte età e le anime svanite: lo sentì migliorare (pare e non è esagerazione) con una frase, con una parola, con un gesto i grandi poeti; lo vide, nel suo studio, preparare, con movenze di leone, le saette lucide e mortali per ferire questo e quel nemico, non di lui ma dell’idealità sua; lo vide tra le coppe misurate improvvisare, con giovani amici ammiranti, piccoli stornelli, fiori di grazia; ascoltò dalle sue labbra, nella religiosa ombra della scuola, la prima ode barbara; ascoltò dalle sue labbra, anzi dalla sua anima, di sul manoscritto, il Canto dell’Amore…
Ella è un’altra Madonna, ella è un’idea
Fulgente dl giustizia e di pietà.
Io benedico chi per lei cadea,
Io benedico chi per lei vivrà:
lo sentì piangere recitando
Di cima a’I poggio allor, da ‘I cimitero,
Giù de’ cipressi per la verde via,
Alta, solenne, vestita di nero
Parvemi riveder nonna Lucia,…
lo sentì tra cento bandiere, avanti tutto un popolo, cui egli impose di non applaudire e che non potè ubbidirgli sino all’ultimo, parlare di Garibaldi morto, in un modo… con una voce… con una eloquenza… che mai Garibaldi non fu tanto vivo, quando allora, nelle anime nostre: tante cose sentì da lui e di lui vide, belle, nobili, alte, mirabili, gloriose, ora d’una semplicità di fanciullo, ora d’una grandezza di eroe, tante, tante! Ma in questo giorno della sua festa solenne, nella quale il maestro riceve un’attestazione di riverenza e di amore e di gratitudine dalla sua patria e da tutto il mondo civile, il suo vecchio scolaro non ha trovato ricordo più soave da evocare, che questo, di quel sorriso ! di quel sorriso che si compiaceva d’un dolore che egli leniva, d’una vita che egli conservava.
Poichè il poeta, il maestro, tutti sanno che è grande; ma soli quelli che gli vissero e vivono da presso, soli specialmente i suoi vecchi e giovani scolari, sanno che egli è anche più buono che grande”.
X AGOSTO
La notte di San Lorenzo, è la notte delle stelle cadenti. E ognuno può farne esperimento come ne ho fatto io. Guizzano in un attimo e dileguano. Il fatto che proprio nella sera di San Lorenzo alcuni uomini iniqui tolsero la vita, senza nemmeno un’ombra di causa che potesse spiegare tanta crudeltà, al nostro padre che lasciava otto figli, suggerisce al poeta l’ immagine che il cielo pianga le sue stelle su questa terra buia e malvagia”.
San Lorenzo, io lo so perchè tanto
di stelle per l’aria tranquilla
arde e cade, perchè sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.
Ritornava una rondine al tetto:
l’uccisero: cadde tra spini
ella aveva nel becco un insetto:
la cena de’ suoi rondinini.
Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell’ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.
Anche un uomo tornava al suo nido
l’uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido:
portava due bambole in dono…
Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano invano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,
oh! d’un pianto di stelle lo inondi
quest’atomo opaco del Male!